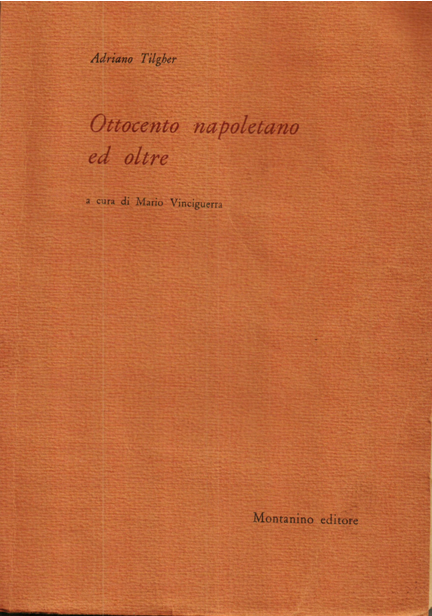
Questa edizione è in possesso degli eredi Mastriani
.
L’EUGÈNE SUE DI NAPOLI: FRANCESCO MASTRIANI E I «LITTERATISSIMI»
‒ Francesco Mastriani? Carneade! Chi era costui? ‒ diranno certo, leggendone il nome sulle colonne dei nostri giornali, parecchi «litteratissimi» di oggi.
Altri, un po’ più eruditi, diranno sprezzantemente ‒ Toh! Guarda un po’! circola ancora quella vecchia mummia, l’Eugène Sue di Napoli! – Chè per essi chiamare Eugène Sue è l’ingiuria massima, e ignorano che ai tempi suoi Eugène Sue guadagnava di diritti d’autore da cinque a seicentomila lire l’anno (lire oro), roba da far svenire più di un «litteratissimo», e che i suoi romanzi furono oggetto di studio appassionato e profondo nientedimeno che di Dostoevskij, che non so se si sarebbe incomodato a studiare altrettanto le prose evocative e liriche dei «litteratissimi»: è vero che per parecchi di essi (e alcuni hanno avuto il coraggio di scriverlo) Dostoevskij, non era che una specie di Eugène Sue, poco più poco meno, che Dio li perdoni!
Studioso dei fenomeni letterari, io mi pongo questo semplice problema: ‒ Come mai accade che, a distanza di mezzo secolo circa dalla morte del suo autore, e in condizione di vita economica, politica e sociale tanto mutate, un grande giornale pubblichi un romanzo di quell’autore, scritto sessant’anni fa, e basti l’annunzio a provocare immediatamente un aumento di richieste di copie? questo è il problema! E su di esso chiamo l’attenzione dei«litteratissimi» di oggi di cui è catecorigamente escluso che l’annunzio di un romanzo d’appendice (dato che un giornale in vena di suicidio abbia l’idea di commissionarne loro uno) faccia aumentare la vendita anche di una sola coipa! Se studiamo le cause del successo che a suo tempo ebbero (e che anche oggi continuano ad avere) i romanzi di Mastriani, noi, credo, troveremo le seguenti.
Innanzi tutto, come tutti i grandi romanzieri popolareschi, Mastriani fa appello a sentimenti semplici, elementari, non dirò eterni, perchè, secondo me, nulla di eterno è nell’uomo, ma soggetti a lentissime variazioni, così lente che, praticamente, per quel che ci riguarda, si possono considerare come eterni, per esempio, nella Cieca di Sorrento, la vendetta, l’amore, il perdono.
In secondo luogo, come da tutti i grandi romanzieri popolareschi, così anche dall’opera di Mastriani si sprigiona una morale, o se la parola vi sembra troppo solenne, un insegnamento, un ammonimento, una conclusione che va nel senso della vita e che è intonata alle sue leggi semplici e profonde: «don Ciccio» Mastriani insegnava la bontà del lavoro, la bellezza dell’onestà, la soddisfazione del lavoro compiuto, il perdono delle offese, la poesia del sacrifico e della rassegnazione, allietata dalla speranza del domani e dalla fede in Dio
Roba che può sembrare vecchiotta, non più a la page, poco moderna e modernistica, ma, riconosciamolo, intonata mirabilmente alla realtà più profonda dell’anima napoletana, anzi meridionale, anzi italiana in genere.
In terzo luogo, i romanzi di Mastriani sono un impasto pel palato popolaresco assai ben riuscito di romanticismo e di verismo. Egli, povero vecchio, dà una gran lezione, senza volerlo, ai «litteratissimi» di oggi: dice loro che la realtà è complessa, è un impasto di bene e di male, di ideale e di reale, di luce e ombra, e che la falsa tanto chi la dipinge tutta in nero seppia quanto che la dipinge tutta in roseo d’aurora. Quando apparve all’orizzonte l’astro di Zola, Mastriani, forse per la prima volta in vita sua, ebbe uno scatto d’immodestia e disse: ‒ Toh, che c’è di nuovo? È quello che vado facendo io da tanti anni! ‒ E infatti una vena di verismo (e forse, al suo tempo, un secolo fa, fu, la sua, almeno per l’Italia, una vera scoperta) scorre nelle sue opere, ma, sempre, le si sovrappone una vena di temperato idealismo, che la fa equilibrio, e che spesso manca nelle opere di un artista pur infinitamente maggiore di lui, come Zola. E in questo voler afferrare tutta la vita, in questo volerla portar tutt nei suoi romanzi, il povero «don Ciccio» dava una lezione che oggi ancora parecchi «litteratissimi» a cui non par di far «vero» se non dipingono tutto col nero di seppia, potrebbero ascoltare non senza qualche profitto.
In quarto luogo, Mastriani scriveva per il popolo, e il Popolo con una gran P. era un secolo fa una realtà, e non una astrazione poetica: una realtà che dalla media borghesia giù fino all’artigiano e al coltivatore abbracciava in una comunità d’intenti di aspirazioni, di idee e di esperienze tutto il paese.
Torniamo allora a scuola da «don Ciccio» Mastriani? Non mi sogno di dir questo, benchè per far dispetto ai «litteratissimi», mi verrebbe gran voglia di dirlo. Conosco troppo bene i suoi limiti per arrischiare sulla di simile. Dico solo che anche da Mastriani, perfino da Mastriani, dal suo persistente successo di un secolo, non certo opera di «comparizi» letterari, può venire loro qualche utile ammaestramento.
Un’altra cosa. Francesco Mastriani è, caso più unico che raro, l’unico romanziere d’appendice italiano che scriva un italiano eccellente. Dirò di più: che, almeno per me il sapore di molti dei suoi romanzi è dato soprattutto dal contrasto tra la materia popolaresca, plebea, napoletanissima, e l’italiano purista in cui sono scritti.«don Ciccio» visse al tempo dell’abate Cesari e di Basilio Puoti, fece tutta la vita il professore di grammatica italiana, conobbe a meraviglia il latino e l’inglese (che insegnò anche), fu insomma un letterato che sapeva il fatto suo. Scorrete i suoi romanzi: vi troverete molte cose che vi faranno arricciare il naso dal punto di vista estetico, ma lingua, sintassi, ortografia sono impeccabili, sempre. Se si degneranno di leggerlo, i «litteratissimi» potranno trovarci più di un utile insegnamento di lingua italiana.
In un suo recente bel sonetto Pasquale Ruocco dipinge il buon vecchio Mastriani mentre in un caffè di via Foria a Napoli butta giù la quotidiana razione di cartelle del suo romanzo:
.
…Ammucchi cartelle su cartelle,
con gli occhi quasi spenti, Professore,
e il tuo pensiero vola al magro pranzo,
mentre un becchino delle Fontanelle
a voce bassa, ingiunge a un avventore:
‒ Zitto! ‘On Ciccio ha da scrivere ‘o rumanzo! ‒
.
ADRIANO TILGHER
.
ADRIANO TILGHER nasce a Resina l’8 gennaio 1887 da padre bavarese. Nel 1897 il giovane Tilgher si trasferisce a Napoli dove inizia la sua formazione frequentando il Liceo Ginnasio Giambattista Vico . Si laurea in Giurisprudenza a soli ventidue anni con una tesi in filosofia del diritto.
Nel 1910 si trasferisce a Torino, dove aveva vinto un concorso per bibliotecario. Nel 1912 sposa la sua compagna storica Livia de Paolis e si trasferisce a Roma perché chiamato a lavorare alla biblioteca alessandrina. Qui inizia un’attività di pubblicista che lo porterà a collaborare con tanti giornali e riviste e dove maturerà la fama di critico attento e polemista. Tra il 1917 e il 1919 incontra molte importanti personalità che lo condurranno a scrivere per La Stampa, per Il Resto del Carlino e per Il Tempo.
Muore a Roma il 3 novembre 1941.
.
